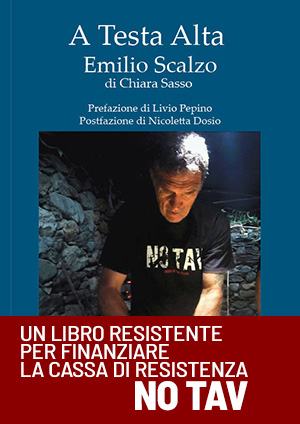Di Marina de Ghantuz Cubbe* ripreso da
Fabbriche recuperate o workers buyout? Un workers buyout è una fabbrica recuperata dagli operai? Neanche per idea. In molti, da a accostano questi due fenomeni commettendo a parere di chi scrive almeno quattro errori. È vero che si tratta, in entrambi i casi, di fenomeni di riappropriazione del lavoro: durante l’ultima crisi economica, in Italia e non solo, molte fabbriche hanno chiuso o sono fallite e gli operai hanno deciso di far ripartire l’azienda continuando a gestirla. Fine dei punti in comune.
Punto uno: Un workers buyout non è una fabbrica recuperata (e viceversa). Nel primo caso infatti, siamo di fronte ad una vera e propria operazione finanziaria per cui nulla può la volontà dei lavoratori se mancano soldi prestati dalle banche, investimenti da parte di istituti finanziari, mutui aperti dai lavoratori stessi: il termine buyout significa rilevare (affittare o acquistare). Quindi un workers buyout è una fabbrica rilevata non recuperata. E non è solo una questione di retorica perché si può recuperare una fabbrica ma è tutta un’altra storia. La definizione “fabbrica recuperata” deriva infatti dall’esperienza delle in Argentina che si sono diffuse dopo la gravissima crisi economica scoppiata nel 2001 e che hanno visto gli operai occupare le fabbriche abbandonate dagli imprenditori. In Italia per ora ne esistono due e gli operai che hanno deciso di intraprendere questa strada si sono ispirati ai lavoratori argentini perché come loro hanno scelto di agire in modo conflittuale (occupare, resistere, produrre).
Punto due: Hanno origini opposte tra loro. Il workers buyout esiste grazie alla legge n. 49 del 1985: la cosiddetta legge Marcora, partigiano cattolico, senatore democristiano, fondatore della corrente di Base, quella più a sinistra della Dc. Per capire quale fosse l’intento del disegno di legge sui workers buyout presentato da Giovanni Marcora, basta leggere gli atti parlamentari e dunque la discussione che, tra 1981 e 1985, ci fu in Parlamento tra Dc, Psi, Pci e Pli. Il Ministro dell’Industria voleva anzitutto potenziare il mondo cooperativo che in quegli anni non riceveva praticamente soldi dallo Stato e pensava che le imprese private fallite, potessero diventare delle cooperative gestite da lavoratori che avrebbero così continuato ad avere un’occupazione. In questo modo, diceva Marcora, si sarebbe ottenuto un duplice risultato: accrescere il numero e la forza economica di quella costellazione di piccole e medie cooperative ancora prive di una organizzazione strutturata; diminuire i costi dello Stato risparmiando sulle spese per la Cassa integrazione guadagni che altrimenti sarebbe spettata ad ogni lavoratore licenziato. Non solo: chi avesse voluto continuare a lavorare doveva rinunciare agli ammortizzatori sociali investendo l’intera somma nella nuova avventura e, in caso di fallimento della neonata cooperativa, non aveva diritto ad alcun tipo di sussidio. Infine la legge dotava le maggiori centrali cooperative di una società finanziaria (Cooperazione finanza e impresa) e stanziava centinaia di miliardi di lire per le operazioni di workers buyout. Marcora muore prima che la legge venga approvata e il progetto viene ripreso in mano dal socialista De Michelis, ministro del governo Craxi. È De Michelis ad aggiungere nel testo della legge una grande quantità di investimenti indirizzati anche alle cooperative già esistenti. È la prima legge che destina così tanto denaro pubblico alla cooperazione.
Per quanto riguarda le fabbriche recuperate italiane invece, sarebbe troppo banale dire che si ispirano solo a quelle argentine. Quando si entra dentro la RiMaflow di Trezzano sul Naviglio, periferia industriale di Milano, si respira aria di politica. Tra i promotori di questa esperienza fatta di manifestazioni, occupazioni, di trattative con il Comune e con la proprietaria dell’immobile (Unicredit leasing), ci sono operai spinti solo dalla perdita del lavoro insieme ad altri che hanno vissuto le assemblee degli anni Settanta in cui gli operai decidevano dal basso sul proprio futuro; ci sono operai che hanno avuto e hanno, esperienze sindacali, dalla FIOM al sindacato di base; c’è chi è stato senatore di Rifondazione comunista prima e Sinistra critica poi. Queste persone il conflitto ce l’hanno nel sangue perché si sono formate (anche) sull’Ordine Nuovo di Gramsci. Il Gramsci che ha scritto Democrazia operaia tanto per intendersi meglio. La forza di riaprire una fabbrica, occuparla ed autogestirla deriva anche dalla consapevolezza politica e storica del fatto che in tutti i periodi di crisi ci sono state occupazioni delle fabbriche. Ebbene sì, ci sono operai che nel 2016 ti citano le occupazioni del 1871 durante la Comune di Parigi, quelle nella Russia del 1917, in Catalogna durante la guerra civile spagnola (1936-1939) e in Italia durante il biennio rosso.
Punto tre: Mercato o morte. Oppure Fuorimercato. A partire da questi presupposti, è facile immaginare che i processi di formazione di un workers buyout e di una fabbrica recuperata sono non solo diversi ma ancora una volta, opposti. Nel primo caso i lavoratori (non per forza esclusivamente operai), vogliono provare a diventare una cooperativa: presentano il progetto a Legacoop e/o a Cooperazione Finanza Impresa e aspettano. Aspettano che queste organizzazioni siano favorevoli e dunque decidano di investire nell’iniziativa. Alberto Zevi, in CFI per trent’anni, spiega chiaramente che o c’è il mercato o la fabbrica non riparte. Anche perché sarebbe folle chiedere ai lavoratori di rinunciare a risparmi come il Trattamento di fine rapporto per un progetto destinato a fallire in partenza. Il mercato c’è se ci sono altre aziende da cui comprare le materie prime necessarie alla produzione ma soprattutto se c’è richiesta di quel prodotto. Dopo che i lavoratori si sono rivolti agli istituti di riferimento e se questi ultimi danno l’ok, si segue il tracciato delineato dalla legge Marcora: si costituisce la cooperativa e chi vuole essere socio deve versare una certa cifra, si chiedono gli interventi finanziari delle banche (di solito Banca Etica) e si ricevono quelli degli istituiti stessi. Questi “interventi” non sono altro che mutui che i lavoratori devono, entro tot anni, estinguere: devono cioè restituire i soldi pagando interessi intorno al 3% quindi decisamente inferiori a quelli che di solito chiedono le banche (7-8%). Una volta ottenuti i finanziamenti hanno i capitali per rilevare in tutto o in parte l’azienda (immobile e macchinari) e finalmente iniziano di nuovo a produrre. Per quanto riguarda la vendita, il mercato in cui i workers buyout sono inseriti è più che altro quello della precedente azienda privata; le aziende da cui comprano le materie prime o certi servizi diventano però soprattutto quelle interne al circuito cooperativo. In questo modo le cooperative già esistenti vendono di più e si rafforza questo tipo di tessuto industriale e manifatturiero.
Gli operai delle fabbriche recuperate operano al contrario: prima occupano e iniziano un tipo di produzione solitamente orientata al riciclo e riuso di materiali e anche di tipo artigianale. Aprono le porte della fabbrica alla cittadinanza offrendo servizi e spazi all’interno; costruiscono una rete di solidarietà sul territorio per cui ottengono l’approvazione della comunità a cui si rivolgono e solo alla fine cercano di avere quella delle Istituzioni. Tra l’altro, ottenere i permessi dal Comune o dal proprietario dello stabile per rimanere a lavorare nella fabbrica di solito è una battaglia. Questo per due motivi: il primo dipende dal fatto che le istituzioni sono state scavalcate e dunque (almeno inizialmente) non vedono di buon occhio l’esperienza; il secondo è che sono gli operai a non voler accettare le condizioni dettate da alcune leggi prima fra tutte quella sulla proprietà. L’iniziativa economica privata, secondo la nostra Costituzione, è libera ed è tutelata. Allo stesso tempo,”Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41). Ecco, gli operai delle fabbriche recuperate decidono di non rispettare la proprietà privata perché una fabbrica abbandonata non ha utilità sociale, danneggia la sicurezza (dell’ambiente e quindi delle persone) e lede anche la dignità umana di chi è rimasto senza lavoro. Ma torniamo al mercato. Nel caso delle fabbriche recuperate la volontà è quella di costruire una rete che oltre ad essere territoriale, sia anche nazionale. Ad esempio Rimaflow insieme ad altre realtà come Sos Rosarno e Sfruttazero, entrambe contro lo sfruttamento di braccianti italiani e immigrati, hanno creato una filiera etica che passi al lato delle imposizioni dettate dalle associazioni di grandi aziende e dalla grande distribuzione. La rete Fuorimercato vuole essere alternativa anche all’organizzazione economica delle cooperative, criticata perché in numerosi casi non ha prodotto altro che l’aumento delle ore di lavoro per un salario non adeguato. Gli operai delle fabbriche recuperate italiane in questo sono stati molto chiari: non hanno voluto costituire un workers buyout perché non volevano aprire mutui, investire risparmi ed entrare a far parte di un movimento, quello cooperativo, in cui non si riconoscono.
Punto quattro: Hanno un valore diverso e problemi differenti. L’unico modo per rispettare entrambe le esperienze è capire quali siano le loro caratteristiche. Magari andando in fabbrica a parlare con i lavoratori.
L’operazione finanziaria di Legacoop e delle altre centrali cooperative, non è caratterizzata di certo dalla conflittualità. Al contrario, è prevista dalla legge, se i lavoratori ottengono i finanziamenti necessari possono investire i propri risparmi e assumere il rischio d’impresa. Una scelta determinante perché significa passare da lavoratori dipendenti a “imprenditori di se stessi”. I soci della neonata cooperativa non recuperano nulla: affrontando uno sforzo economico per molti di loro enorme, affittano o acquistano la fabbrica. È questo il valore che ha il workers buyout: la grande responsabilità economica assunta dai lavoratori. Un cambiamento radicale rispetto al passato, a cui si sommano le difficoltà di reinserimento nelle dinamiche del mercato.
I workers buyout fanno parte a pieno titolo del mondo della cooperazione ma attenzione: è una possibilità che dalla maggior parte dei lavoratori è considerata l’unica alternativa possibile; nascono più per necessità che non per una originaria intenzione di cooperare. La trasmissione della conoscenza, la sensibilizzazione ai valori della cooperazione come la democrazia interna e la partecipazione, sono problematiche di cui gli istituti cooperativi dovrebbero riuscire a farsi maggiore carico invece di ricoprire quasi esclusivamente il ruolo di investitore finanziario. A maggior ragione perché all’interno del mondo cooperativo, il workers buyout rappresenta l’unico caso in cui l’autogestione dei lavoratori è una scelta dettata prima di tutto dall’esigenza di non perdere il proprio posto di lavoro e non da una precedente volontà di cooperare.
Le fabbriche recuperate presentano invece la situazione contraria: queste esperienze nascono proprio dal rapporto di solidarietà che in un momento difficile i lavoratori instaurano tra loro e vanno semmai incontro a difficoltà economiche dovute proprio alla scelta di non investire i risparmi ma di cercare altre modalità di finanziamento. Quello delle fabbriche recuperate è un processo di riappropriazione del lavoro caratterizzato da un’azione conflittuale costante che è necessaria per garantire una continuità all’esperienza di recupero e quindi costruire un’alternativa vera alla disoccupazione. Nel momento in cui l’informazione associa i due fenomeni e definisce i workers buyout fabbriche recuperate, ignora – in buona fede o intenzionalmente – il valore di queste ultime e dell’autogestione conflittuale praticata con fatica e determinazione da anni, ogni giorno.
*Giornalista praticante, collabora con l’associazione Articolo21 per la libertà di informazione. Si è laureata nel 2016 in Formazioni sociali contemporanee all’Università di Bologna con una tesi sulle fabbriche recuperate e i workers buyout. L’analisi dei due fenomeni è stata realizzata intervistando sindacalisti, rappresentanti delle organizzazioni cooperative e soprattutto i lavoratori di quattro diverse fabbriche italiane, due workers buyout e due fabbriche recuperate.